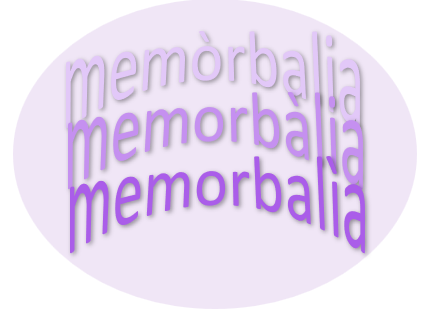Mario, Ambel, gennaio 2025
Sono profondamente amareggiato, ma non stupito da quanto emerge dal dibattito sollevato dalla intervista al Giornale del Ministro del Merito. Andrebbe anzitutto chiarito che (al di là delle precisazioni fornite) non si tratta di “Indicazioni”, ma di “Programmi”, nel senso più retrivo del termine, ovvero di una serie di contenuti da imporre alle scuole e non di finalità da perseguire e obiettivi da raggiungere. Ed è il primo passo indietro. In più, sono contenuti che delineano un preciso impianto ideologico e di parte.
Si tratta infatti di un’azione con motivazioni e implicazioni meramente politiche, ovvero di un tentativo (di regime?) di orientare la vita scolastica nella direzione di marcia gradita al governo e alle forze che lo sostengono: in questo caso in senso reazionario e nostalgico, meritocratico e nazionalista. Per questo diventa improprio e fuorviante trattare le proposte del Ministro in ottica scolastica, curricolare e pedagogica. Anche se andrà comunque fatto, per contrastarne l’applicazione ed evitare i guasti conseguenti. Del resto, se si pensa che in America, in particolare in quella che ha eletto Trump, in alcune comunità e nelle loro scuole e nei loro Stati si ritiene più opportuno spiegare la creazione di Adamo ed Eva anziché l’evoluzionismo darwiniano, pregi e limiti compresi; se si pensa che nelle scuole islamiche la base degli insegnamenti è il Corano, non credo che ci si debba stupire se questo governo propone di leggere la Bibbia o di privilegiare lo studio della storia occidentale o se rispolvera il latino addirittura come strumento per combattere l’analfabetismo funzionale. Si tratta di un’azione identitaria conservatrice non per la cultura classica, ridotta anzi a paccottiglia strumentale, o l’incremento delle competenze linguistiche, ma contro: contro la società inclusiva, l’accoglienza culturale o pratica di ogni forma di diversità, il pericolo islamico e quella che a destra chiamano la cultura “woke”, la “fuffa globalista”, il “politicamente coretto”, bla bla…
Certo, se si pensa alla faticosa storia e alla realtà attuale della scuola pubblica del nostro paese, che avrebbe certo bisogno di radicali cambiamenti ma non certo di questi, vien quasi da piangere, ma Valditara non sta pensando a come migliorare la scuola: compie un atto politico e ideologico di parte e tenta di imporre alla scuola italiana le convinzioni sue e dei suoi sodali, nella speranza di accrescere la sua base di consenso. Va da sé che è inutile e fuori luogo discuterne nel merito, ovvero discutere, entro i confini di un dibattito pedagogico e culturale se sia il caso o meno di leggere la Bibbia fin dalla scuola primaria come fonte di conoscenza storica: è evidente che si tratta di una discussione che può avere un senso sul terreno ideologico o confessionale, mentre in una analisi storiografica o di didattica della storia è semplicemente una pericolosa stupidaggine. E lo stesso vale per il latino e le altre proposte. Sull’insegnamento delle lettere classiche, tra l’altro, ci sarebbe bisogno da tempo di una seria riflessione culturale e pedagogica (A chi e a che cosa serve? Fatto quando e come?), che il Ministero e i licei hanno sempre eluso proprio per non alienarsi coloro che oggi plaudono al suo ritorno, 60 anni dopo l’unica vera riforma della scuola italiana.
Ciò che stupisce quindi non è ciò che il Ministro Valditara intende fare. Ciò che stupisce, amareggia e disorienta è che glielo si consenta. E non è certo una buona ragione che abbia vinto le elezioni. Il fatto di vincere le elezioni non autorizza un partito o una coalizione a imporre alla scuola pubblica le proprie idee. Ciò che stupisce e amareggia è l’appoggio di intellettuali e accademici e, se è vero che sono avvenute le consultazioni di cui il Ministro parla, è assai grave che abbia ottenuto il consenso o il viatico non tanto di associazioni di genitori o di professionisti di settori diversi, ma delle associazioni di docenti e di dirigenti scolastici. Del resto è questo il vero problema: se la scuola, compatta e ferma non vi si oppone in modo netto e inequivocabile, se nel dibattito politico e culturale ci si limita alla logorante e prevedibile polemica fra favorevoli e contrari sul terreno delle collocazioni politiche, di cui non è difficile immaginare le rispettive argomentazioni, se si trova persino qualche pedagogista o esperto di scienze dell’educazione disposto ad avallare o addirittura a sostenere quelle linee di condotta, mentre tutti gli altri tacciono o bisbigliano, allora la scuola e il paese non possono far altro che aspettarsi e tenersi la scuola che si meritano, ovvero quella delineata in quell’intervista. D’altro canto basta pensare alla “lettera dei 600” del 2017 per immaginare consessi anche scolastici ben lieti di leggere oggi i propositi del Ministro Valditara e che possono orgogliosamente fregiarsi del merito (ognuno ha i suoi) di averne anticipato l’esigenza e la direzione. Così com’è fin troppo facile pensare agli inutili, quando non dannosi, corsi di latino organizzati da sempre in molte scuole secondarie di primo grado, per avere conferma di soluzioni inutili per problemi reali (che non sono le competenze linguistiche, ma le richieste di prerequisiti da parte dei licei). Oppure si possono scorrere molte delle domande che vengono proposte nei vari attuali concorsi a cattedra: nel potpourri caotico dove non ci si fa mancare nulla, in cui si è trasformato il “sapere” della scuola dopo decenni di accumulazione bulimica di contenuti, non è certo difficile trovare l’eco, che ora sarà certamente crescente, dei filoni di pensiero esposti dal Ministro, con particolare riguardo all’epica, alla letteratura nazionale dei primi secoli e alla cultura “occidentale” entro la scuola dell’obbligo. Nella scuola italiana, la persistenza di un filone conservatore carsico, che è sempre sopravvissuto a ogni tentativo di rinnovamento inclusivo e progressista, avrà ora finalmente il suo avallo istituzionale.
Certo non invidio chi è ancora a scuola e guarda invece con apprensione alle anticipazioni mediatiche dei “cambiamenti” cui sembra dovrà attenersi, ma non trovi la scusa di esservi costretto. Spetta solo alla sua dignità e competenza professionale assecondarle o opporsi. Anche se la dignità e la competenza professionale sono di quelle cose che bisogna darsi da sé o trovarle unendosi insieme con altri. Di certo non arrivano dai governi, soprattutto se attratti dalla rimodulazione delle identità collettive, dal sistema economico-finanziario o dalle piattaforme che gestiscono il potere mediatico e digitale. La libertà d’insegnamento è un valore complesso, non arbitrario, ma ogni tanto bisogna ricordarsi che esiste e che, in fondo, del che cosa e del come si insegna si è in gran parte liberi e quindi responsabili, a livello sia collegiale che personale. E chi (speriamo di scamparla) si metterà a parlare del serpente, della mela, del peccato di Eva e della costola di Adamo nella scuola primaria; o ricomincerà a privilegiare lo studio della storia e della cultura “occidentali” in ottica identitaria ed euro(occidento)centrica o nazionalista, come si faceva nella scuola gentiliana e prima dell’odiato (a destra) sessantotto, o a insegnare il latino opzionale in seconda media, anticipando di fatto la discriminazione di classe e di privilegio dei destini individuali dei suoi allievi in piena età di scuola dell’obbligo, ne sarà individualmente e soggettivamente responsabile, anche se istituzionalmente coperto e incentivato.
E su tutto questo proliferare di proposte e del dibattito che ne segue, aleggia la grande rimozione: così come, nella patacca elettorale americana, il rovescio del conservatorismo da America profonda di Trump è la distopia del capitalocene in versione Elon Musk, a scuola, più semplicemente, il rovescio dell’enfasi sul “ritorno alle radici” sarà l’asservimento all’invasione dei dispositivi digitali spacciati per gestibili “strumenti”, affidata alle emanazioni educative delle piattaforme che gestiscono la trasformazione dei dati di tutti in guadagni di pochi e governano la produzione e la diffusione “occidentale” di senso. E qui, il consenso di vari strati di intellectual servant e di utilizzatori finali, spesso incompetenti, è purtroppo ancora più ampio. Per averne un’idea, M. Guastavigna, Niente di nuovo sul fronte artificiale, gessetti colorati, dicembre 2023.